 La gestione del punto di vista, specie per quanto riguarda il mezzo cinematografico, è di primaria importanza affinché una narrazione risulti significativa e coerente. Non solo perché il punto di vista (o la combinazione dei punti di vista) costituisce lo “sguardo” peculiare di un film, mentre la ripartizione e il bilanciamento ne fondano la drammaturgia, ma perché, prima di tutto, esso regola la partecipazione dello spettatore, che è tanto diversa quanto più è ampia la distanza tra il soggetto dell’enunciazione (gli o l’autore) e il protagonista (o i protagonisti) della storia. Pertanto, la distribuzione e la modulazione del punto di vista sono operazioni piuttosto complicate e delicate, cui bisognerebbe prestare molta attenzione per riuscire a comunicare informazioni, idee e sensazioni in maniera efficace. Conseguire una buona padronanza del punto di vista – nelle sue declinazioni tecniche e artistiche – resta tuttavia un traguardo difficile, che si ottiene o per esperienza o per innato talento. Non a caso, quando ci si imbatte nelle opere prime o nei film realizzati da mestieranti poco esperti, il problema più ricorrente interessa proprio l’articolazione del punto di vista. Molti di questi prodotti, benché interessanti e/o gradevoli, spesso tradiscono una sorta di incertezza riguardo al messaggio, come se fosse svincolato da un referente ufficiale. Si obietterà che, in alcuni casi, il referente possa essere extradiegetico e onnisciente (focalizzazione zero), circostanza facilmente riconoscibile a causa dell’emancipazione e distanza narrative rispetto ai personaggi e agli eventi. Nella maggior parte dei casi, comunque, il problema riguarda la focalizzazione interna (quando cioè il narratore assume il ruolo di un personaggio) e interessa principalmente il punto di vista dei protagonisti – che sono quelli a cui non si è disposti a concedere un arbitrio al di fuori della storia narrata (l’allontanamento, la sparizione, l’offuscamento e l’inattività). Difficoltà maggiori sembrano sussistere quando la narrazione è spartita tra due o più protagonisti (focalizzazione multipla), perché in quel caso sarà l’equidistanza dei punti di vista a mantenere la storia in equilibrio, un bilanciamento delicatissimo in cui il margine di errore sarà davvero minimo. Nel caso del racconto corale, ad esempio, la miglior strategia sembrerebbe quella di mantenere una distanza “di sicurezza” tra lo spettatore e i protagonisti, in maniera da impedire un’identificazione unica ed esclusiva e, perciò, una comprensione limitata o fuorviante del testo – maestro nel racconto corale e nell’orchestrazione del punto di vista era, ad esempio, il regista Robert Altman. Nel caso più elementare della storia a due, in cui si incontrerà una coppia coinvolta in un rapporto più o meno importante, la gestione il punto di vista potrà rivelarsi tutt’altro che semplice. Oltre a valere sempre la regola della buona distanza, l’incisività dei personaggi e del loro legame risulterà tanto più potente quanto più il punto di vista sarà quello della coppia come entità unica (condivisione del campo e/o spartizione equilibrata dei tempi e degli spazi in campo, predilezione per le semisoggettive piuttosto che per le soggettive) – Titanic (James Cameron, 1997) può essere citato come esempio virtuoso. Nel caso in cui, invece, non si desideri adottare tale strategia narrativa, occorrerà fare una scelta e prediligere un personaggio (e un punto di vista) cui subordinare l’altro. Ed è qui che casca l’asino. Quando si parla di linguaggio cinematografico, chiaramente, nessuna regola è fissata ad infinitum e,
La gestione del punto di vista, specie per quanto riguarda il mezzo cinematografico, è di primaria importanza affinché una narrazione risulti significativa e coerente. Non solo perché il punto di vista (o la combinazione dei punti di vista) costituisce lo “sguardo” peculiare di un film, mentre la ripartizione e il bilanciamento ne fondano la drammaturgia, ma perché, prima di tutto, esso regola la partecipazione dello spettatore, che è tanto diversa quanto più è ampia la distanza tra il soggetto dell’enunciazione (gli o l’autore) e il protagonista (o i protagonisti) della storia. Pertanto, la distribuzione e la modulazione del punto di vista sono operazioni piuttosto complicate e delicate, cui bisognerebbe prestare molta attenzione per riuscire a comunicare informazioni, idee e sensazioni in maniera efficace. Conseguire una buona padronanza del punto di vista – nelle sue declinazioni tecniche e artistiche – resta tuttavia un traguardo difficile, che si ottiene o per esperienza o per innato talento. Non a caso, quando ci si imbatte nelle opere prime o nei film realizzati da mestieranti poco esperti, il problema più ricorrente interessa proprio l’articolazione del punto di vista. Molti di questi prodotti, benché interessanti e/o gradevoli, spesso tradiscono una sorta di incertezza riguardo al messaggio, come se fosse svincolato da un referente ufficiale. Si obietterà che, in alcuni casi, il referente possa essere extradiegetico e onnisciente (focalizzazione zero), circostanza facilmente riconoscibile a causa dell’emancipazione e distanza narrative rispetto ai personaggi e agli eventi. Nella maggior parte dei casi, comunque, il problema riguarda la focalizzazione interna (quando cioè il narratore assume il ruolo di un personaggio) e interessa principalmente il punto di vista dei protagonisti – che sono quelli a cui non si è disposti a concedere un arbitrio al di fuori della storia narrata (l’allontanamento, la sparizione, l’offuscamento e l’inattività). Difficoltà maggiori sembrano sussistere quando la narrazione è spartita tra due o più protagonisti (focalizzazione multipla), perché in quel caso sarà l’equidistanza dei punti di vista a mantenere la storia in equilibrio, un bilanciamento delicatissimo in cui il margine di errore sarà davvero minimo. Nel caso del racconto corale, ad esempio, la miglior strategia sembrerebbe quella di mantenere una distanza “di sicurezza” tra lo spettatore e i protagonisti, in maniera da impedire un’identificazione unica ed esclusiva e, perciò, una comprensione limitata o fuorviante del testo – maestro nel racconto corale e nell’orchestrazione del punto di vista era, ad esempio, il regista Robert Altman. Nel caso più elementare della storia a due, in cui si incontrerà una coppia coinvolta in un rapporto più o meno importante, la gestione il punto di vista potrà rivelarsi tutt’altro che semplice. Oltre a valere sempre la regola della buona distanza, l’incisività dei personaggi e del loro legame risulterà tanto più potente quanto più il punto di vista sarà quello della coppia come entità unica (condivisione del campo e/o spartizione equilibrata dei tempi e degli spazi in campo, predilezione per le semisoggettive piuttosto che per le soggettive) – Titanic (James Cameron, 1997) può essere citato come esempio virtuoso. Nel caso in cui, invece, non si desideri adottare tale strategia narrativa, occorrerà fare una scelta e prediligere un personaggio (e un punto di vista) cui subordinare l’altro. Ed è qui che casca l’asino. Quando si parla di linguaggio cinematografico, chiaramente, nessuna regola è fissata ad infinitum e,  accanto alle naturali evoluzioni tecniche, estetiche e sintattiche, vigerà sempre una certa libertà “discorsiva”. D’altro canto, sebbene l’originalità sia sempre cosa gradita, alcune soluzioni creative potrebbero dimostrarsi inefficaci rispetto a collaudate formule tradizionali, e quelle concernenti la focalizzazione restano difficilmente emendabili…
accanto alle naturali evoluzioni tecniche, estetiche e sintattiche, vigerà sempre una certa libertà “discorsiva”. D’altro canto, sebbene l’originalità sia sempre cosa gradita, alcune soluzioni creative potrebbero dimostrarsi inefficaci rispetto a collaudate formule tradizionali, e quelle concernenti la focalizzazione restano difficilmente emendabili…
Per fare un esempio pratico si potrebbero citare due film che, per orchestrazione del punto di vista, hanno più di un aspetto in comune: Room (Lenny Abrahamson, 2015) e Mommy (Xavier Dolan, 2014). Entrambi i film, infatti, si occupano del rapporto madre/figlio sullo sfondo di una situazione drammatica e complicata, in cui il punto di vista ricopre un ruolo fondamentale nel riferire gli avvenimenti e il loro significato più intimo. Se da un lato i mondi descritti riflettono la peculiare condizione psicologica e sociale dei protagonisti (i figli) – ricordando delle gabbie – dall’altro coinvolgono in anche le co-protagoniste (le madri) – custodi e vittime delle circostanze – che tentano di risolvere le discrepanze tra il mondo esterno e la prigione, tra la libertà e la reclusione, tra la normalità e l’anomalia. Tuttavia, se Abrahamson e Dolan dimostrano pari abilità nel tratteggiare le incomprensioni e le difficoltà incontrate dai due protagonisti, restituendo tutta la complessità del loro particolare status ricettivo ed espressivo, essi sembrano gestire le figure materne in modo completamente diverso. Nei passaggi del film in cui è necessario spostare la narrazione dalla “visione del protagonista” al “protagonista visto” entrambi i registi sfruttano bene le oggettive (reali e irreali). Ne sono esempio le sequenze più evocative dei due film: la prima è quella in cui una plongée mostra Jack sdraiato sul furgoncino facendo, finalmente, esplodere il campo in altezza (Room); mentre la seconda è quella in cui Steve, volteggiando a occhi chiusi sul suo skateboard, estende con la mani il campo in larghezza, portando il formato da un 4/3 a un 16/9 (Mommy). Si tratta di due momenti importanti, in cui la libertà dei due protagonisti si esprime nella rimodulazione dello spazio, sia fisico sia virtuale, della scena. Nei passaggi in cui si tenta di integrare l’azione o il pensiero di altri personaggi, invece, i due film utilizzano strategie differenti. Se lo slittamento del punto di vista dal protagonista ad altre figure non ne sminuisce il ruolo, di certo influisce sull’identificazione dello spettatore e, di conseguenza, sulla sua comprensione dello “sguardo” totale. Tuttavia, se è Abrahamson a compiere meno conversioni, realizzando la prima parte di Room in modo chiaro e costante, è Dolan a risolvere gli scambi in Mommy nella maniera più convincente e originale.
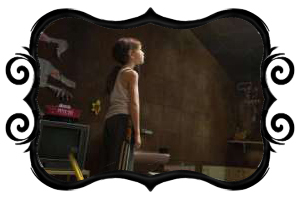 La ragione della differenza risiede, prima di tutto, nel tipo di rapporto che i figli intrattengono con le madri. In Room, il piccolo Jack possiede una conoscenza limitata del mondo rispetto alla madre Joy e questo crea un divario (oltre a quello anagrafico e cognitivo) piuttosto ampio. Abrahamson avvicina e tiene insieme gli sguardi sfruttando (visivamente) il punto di vista innocente del bambino, ma imprigionandolo in uno spazio drammatico che è riflesso del punto di vista materno. Se nella prima parte ciò sembra funzionare alla perfezione – a causa dell’iniziale mancanza di informazioni e del vincolo d’ambientazione – nella seconda parte, in cui diventa necessario integrare altri personaggi, spazi più ampi ed eterogenei e una temporalità più articolata, la prospettiva sembra distorcersi. Alternato tra madre e figlio, il punto di vista si scinde (si risica sulle soggettive, appaiono meno inquadrature di coppia, si moltiplicano le sequenze con uno solo dei personaggi) e la focalizzazione interna salta. A questo punto lo spettatore non può far altro che adattarsi alla situazione e ricevere le informazioni passando da un corpo all’altro senza possibilità di identificazione. E’ qui che il film sembra assumere un taglio cronachistico, meno intimo, meno esperienziale e, perciò, meno coinvolgente. Mommy, invece, pur non incontrando le difficoltà di Room – che, in termini di possibilità narrative, è forse più rigido – sopperisce alla dispersione del punto di vista mantenendo, fin da principio, una distanza strategica da entrambi i personaggi (totale assenza di soggettive, prevalenza di semisoggettive, taglio documentaristico). Stabilire chi sia il protagonista in Mommy è una faccenda piuttosto complicata, e se inizialmente la storia sembra raccontata dal punto di vista di Diane, successivamente le licenze narrative e la centralizzazione di Steve sembrano suggerire una realtà diversa. Questo accade perché, di fatto, Mommy è un prodotto tanto naif quanto libero e innovativo. Nell’affrontare la questione del punto di vista Dolan sceglie di servirsi della focalizzazione esterna (racconto oggettivo), ma allo stesso tempo non rinuncia a calarsi, a fasi alterne, nei panni di entrambi i personaggi principali. Ce ne accorgiamo quando sceglie di rendere irreali, ma anche più intime e potenti, le uniche due soggettive presenti nel film, realizzandole come se fossero proiezioni della psiche più che della vista. Una è quella in cui Steve, alle prese con il karaoke in un locale, è vittima di una crisi paranoide; l’altra è quella in cui Diane immagina come sarebbe potuto essere il futuro del figlio. Mettendo sullo stesso piano l’allucinazione di Steve e l’epifania di Diane, Dolan riesce a tenere perfettamente in equilibrio realtà ricettive diverse, in cui convergono coscienze e sentimenti opposti.
La ragione della differenza risiede, prima di tutto, nel tipo di rapporto che i figli intrattengono con le madri. In Room, il piccolo Jack possiede una conoscenza limitata del mondo rispetto alla madre Joy e questo crea un divario (oltre a quello anagrafico e cognitivo) piuttosto ampio. Abrahamson avvicina e tiene insieme gli sguardi sfruttando (visivamente) il punto di vista innocente del bambino, ma imprigionandolo in uno spazio drammatico che è riflesso del punto di vista materno. Se nella prima parte ciò sembra funzionare alla perfezione – a causa dell’iniziale mancanza di informazioni e del vincolo d’ambientazione – nella seconda parte, in cui diventa necessario integrare altri personaggi, spazi più ampi ed eterogenei e una temporalità più articolata, la prospettiva sembra distorcersi. Alternato tra madre e figlio, il punto di vista si scinde (si risica sulle soggettive, appaiono meno inquadrature di coppia, si moltiplicano le sequenze con uno solo dei personaggi) e la focalizzazione interna salta. A questo punto lo spettatore non può far altro che adattarsi alla situazione e ricevere le informazioni passando da un corpo all’altro senza possibilità di identificazione. E’ qui che il film sembra assumere un taglio cronachistico, meno intimo, meno esperienziale e, perciò, meno coinvolgente. Mommy, invece, pur non incontrando le difficoltà di Room – che, in termini di possibilità narrative, è forse più rigido – sopperisce alla dispersione del punto di vista mantenendo, fin da principio, una distanza strategica da entrambi i personaggi (totale assenza di soggettive, prevalenza di semisoggettive, taglio documentaristico). Stabilire chi sia il protagonista in Mommy è una faccenda piuttosto complicata, e se inizialmente la storia sembra raccontata dal punto di vista di Diane, successivamente le licenze narrative e la centralizzazione di Steve sembrano suggerire una realtà diversa. Questo accade perché, di fatto, Mommy è un prodotto tanto naif quanto libero e innovativo. Nell’affrontare la questione del punto di vista Dolan sceglie di servirsi della focalizzazione esterna (racconto oggettivo), ma allo stesso tempo non rinuncia a calarsi, a fasi alterne, nei panni di entrambi i personaggi principali. Ce ne accorgiamo quando sceglie di rendere irreali, ma anche più intime e potenti, le uniche due soggettive presenti nel film, realizzandole come se fossero proiezioni della psiche più che della vista. Una è quella in cui Steve, alle prese con il karaoke in un locale, è vittima di una crisi paranoide; l’altra è quella in cui Diane immagina come sarebbe potuto essere il futuro del figlio. Mettendo sullo stesso piano l’allucinazione di Steve e l’epifania di Diane, Dolan riesce a tenere perfettamente in equilibrio realtà ricettive diverse, in cui convergono coscienze e sentimenti opposti. Egli si pone tra le parti raccontando l’ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) sia vissuto sia subito, oscillando tra l’ottica frenetica e distratta di Steve e quella turbata e contemplativa di Diane. L’effetto ottenuto da Dolan è quello di permettere allo spettatore una doppia identificazione congiunta e intensissima, raramente conseguita nel panorama cinematografico.
Egli si pone tra le parti raccontando l’ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) sia vissuto sia subito, oscillando tra l’ottica frenetica e distratta di Steve e quella turbata e contemplativa di Diane. L’effetto ottenuto da Dolan è quello di permettere allo spettatore una doppia identificazione congiunta e intensissima, raramente conseguita nel panorama cinematografico.
